L’ignoto di James Joyce e l’Odissea caotica dell’esistenza
“Ulisse” di James Joyce. Umberto Eco nel saggio “Sei passeggiate nei boschi narrativi” fa una differenza tra la letteratura che vuole ricostruire un ordine nelle cose attraverso una narrazione precisa e ben definita, e poi invece un altro modus scribendi (quello che comprende gli autori i quali sono mossi dal profondo desiderio di rappresentare la […]
“Ulisse” di James Joyce.
Umberto Eco nel saggio “Sei passeggiate nei boschi narrativi” fa una differenza tra la letteratura che vuole ricostruire un ordine nelle cose attraverso una narrazione precisa e ben definita, e poi invece un altro modus scribendi (quello che comprende gli autori i quali sono mossi dal profondo desiderio di rappresentare la realtà caotica dell’esistenza, cosa che si riflette anche nelle tecniche narrative).
Malgrado non abbia scritto un gran numero di opere, James Joyce è un colosso della letteratura mondiale che si inserisce senz’altro nella seconda categoria. La scrittura di Joyce è complessa e non accessibile a tutti, tuttavia è funzionale a descrivere la variopinta natura umana. Trova spazio in ciò il concetto di ignoto, fra le altre cose, e riabbraccia anche la mitologia greca.
L’ignoto di Ulisse: il nostos.
L’opera più famosa di James Joyce è “Ulisse”. Questa figura non ha bisogno di presentazioni. Personaggio fortunatissimo che viene ad oggi ancora ripreso come modello in canzoni, opere letterarie ed artistiche. Tra le peculiarità di questo eroe, oltre all’eccezionale astuzia, vi è la voglia di scoprire. Anche se è vero che Ulisse è lontano dalla sua patria e che intraprende un nostos per baciare di nuovo la sua Itaca, nel corso del suo lungo viaggio mostra di voler andare oltre le cose umane, oltre l’ignoto.
Uno dei momenti più celebri in cui Ulisse è protagonista, non è solamente l’opera omerica, ma “La Divina Commedia“. Dante nel XXVI Canto dell’Inferno incontra Ulisse e Diomede. Il sommo poeta mette in risalto il folle volo dell’eroe che va oltre i limiti concessi all’uomo e vuole scoprire di più, spingendo anche i compagni alla conoscenza. Pronuncia la famosa frase “fatti non foste a viver come bruti“.
Lo Stream of Consciousness di James Joyce.
“Ulisse” di James Joyce è quasi una parodia dell’Odissea, con cui si trova sempre in parallelo ma in modo rivoluzionario e peculiare grazie a tecniche tipiche del Modernismo, la corrente di cui Joyce è il principale esponente. La più celebre è il “flusso di coscienza”, in inglese Stream of Consciousness, conosciuta e ripresa da molti.
Celebre la canzone dei Dream Theater che riporta proprio questo titolo. Per flusso di coscienza si intende uno stile narrativo che esprime liberamente i pensieri della persona, il flusso senza limiti, così come vengono pensati prima che vengano messi in ordine. Il risultato di ciò è una narrazione spesso priva di punteggiatura.
Esempio emblematico di ciò è il monologo di Molly Bloom che chiude proprio “l’Ulisse”. Infatti, nel romanzo si racconta di una sola giornata a Dublino vissuta da Leopold Bloom, da sua moglie Molly Bloom e Stephen Dedalus, rispettivamente rappresentano Ulisse, Penelope e Telemaco. Proprio Molly riflette per ben quaranta pagine in un flusso di coscienza in cui troviamo solamente due segni di punteggiatura. Riprendendo Eco, sostanzialmente è come vedersi davanti un qualsiasi momento in cui un essere umano riflette, parte da qualcosa, per poi espandere i propri pensieri. Spesso da queste riflessioni si scardina una sorta di illuminazione, come una scoperta di qualcosa di ignoto o mistico.
L’Epiphany di James Joyce.
Questa apparizione improvvisa, che è solo uno sprazzo di conoscenza, James Joyce la chiamò “Epiphany”. Questo termina deriva dal greco ἐπιϕάνεια ovvero manifestazione. Indicava in antichità proprio la manifestazione di un dio attraverso segni soprattutto della natura. Tale mitologia ha grande spazio nella letteratura modernista e non solo. Joyce usava questa tecnica narrativa per indicare una rivelazione che coglie alla sprovvista i personaggi e che non è materiale, come la scoperta di un luogo, bensì spirituale. In tal senso, ci indirizza verso quell’ignoto così tanto ricercato dall’uomo e filosoficamente lo pone di fronte anche ai suoi limiti e debolezze.
In tal senso, il tempo assume un valore totalmente diverso: L’Ulisse è un romanzo lunghissimo ma che si svolge in una giornata, il 16 giugno 1904. Diciotto capitoli, diciotto episodi in cui lo stile cambia continuamente e varia dal parodistico al realistico. Il tempo si dilata poiché ne conta la percezione, conta ciò che pensa l’uomo e come vive. Il caos dell’esistenza si traduce in momenti come epifanie, alla ricerca di consapevolezza e di mistero.
Leggi anche: Indugio e suspense: Umberto Eco e Alfred Hitchcock a confronto

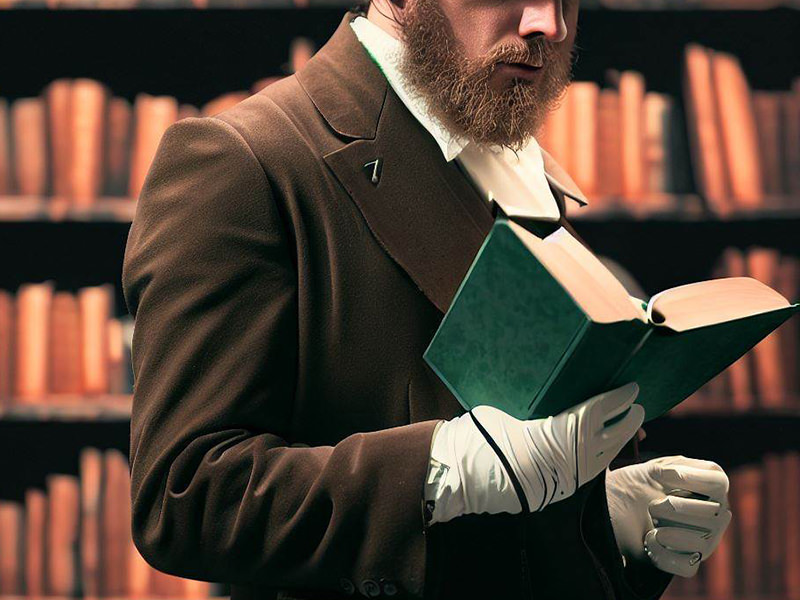
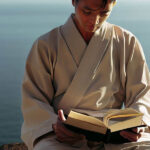
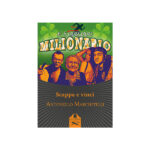
No Comment! Be the first one.